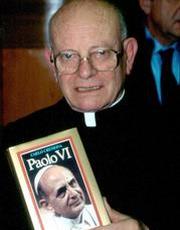04 ottobre 2023

«Percorsi di pace»
per la sesta Giornata delle Catacombe
«Percorsi di Pace» è il titolo dell’iniziativa voluta il 7 ottobre prossimo dalla Pontificia Commissione di Archeologia Sacra nella VI Giornata delle Catacombe-Edizione d’Autunno. Saranno gratuitamente visitabili, su prenotazione, alcuni siti che generalmente sono chiusi al pubblico dislocati a Roma e in varie regioni d’Italia. In un momento storico segnato da drammatiche conflittualità, si guarda a quelle immagini catacombali che ancora a distanza di secoli suscitano una riflessione sulla fratellanza e la pace.
Dopo il successo dell’apertura il 18 marzo scorso di sette catacombe romane, per questa Edizione d’Autunno si offre la possibilità di visitare sei complessi ipogei della Roma sotterranea: Santa Tecla, San Lorenzo, Pretestato, Vigna Chiaraviglio, l’ipogeo degli Aureli e Generosa.
In alcuni casi avranno luogo conferenze, come quella organizzata sulla figura di Sant’Antioco nel Palazzo del Capitolo dell’omonimo comune, un’isoletta nell’estremo sud ovest della Sardegna. Ci sono anche laboratori dedicati ai bambini, come quello sulle epigrafi cristiane nel Comprensorio callistiano a via Appia Antica a Roma, o quello sui simboli cristiani presso le Catacombe di S. Savinilla nel comune laziale diNepi. Le iniziative si chiuderanno con una messa presieduta da monsignor Pasquale Iacobone, presidente della Pontificia Commissione di Archeologia Sacra, ad Albano Laziale.
Alcuni simboli nelle decorazioni nelle catacombe, che rappresentano episodi e personaggi dell’Antico e del Nuovo Testamento, o scenari bucolici e paradisiaci, o momenti di vita quotidiana, sono molto noti, ma si possono scoprire sfumature interessanti. L’immagine dell’agnello, ad esempio, vittima sacrificale per eccellenza, viene utilizzata per rappresentare il Cristo, ma anche gli apostoli e i fedeli e può figurare anche, più semplicemente, una estrema sintesi del mondo pastorale. C’è poi la colomba che simboleggia l’anima che ha raggiunto la pace divina, nonché l’intervento salvifico di Dio, lo Spirito santo, e, se rappresentata con un ramoscello di ulivo, riporta alla pace dopo il diluvio universale. C’è poi l’àncora che suggerisce immediatamente l’idea della sicurezza di una nave nel porto, ma che può essere vista insieme con il faro, che con la sua luce indica l’approdo finale della navigazione: la salvezza. Meno conosciuta la rappresentazione della lepre, simbolo del fedele che fugge dalle insidie del mondo.
Se sono tanti i significati delle decorazioni, non meno importante è il messaggio stesso delle catacombe. La comunità cristiana ha ben presto avvertito la necessità di uno spazio destinato ad accogliere i fedeli in un riposo comune e in particolare si desiderava garantire a tutti i suoi membri, anche a quelli più poveri, una sepoltura dignitosa, esprimendo dunque un forte richiamo all’uguaglianza e alla fratellanza. È con questo spirito che nascono e si sviluppano le prime catacombe, composte da reti di gallerie sotterranee scavate talvolta riutilizzando spazi preesistenti. Garantivano l’apertura di più pile di loculi sovrapposti oppure forme di deposizione più articolate, come le tombe a mensa, gli arcosoli e i cubicoli. Sono spazi definiti cimiteri con un termine che deriva dal greco e indica «il luogo del riposo, che rispecchiano con esattezza la concezione cristiana della morte come tempo sospeso in attesa della Risurrezione.
Il valore delle Giornate delle Catacombe, che hanno preso il via nel 2018, è quello di offrire un percorso di visita e conoscenza che introduca alle fonti monumentali, testi diretti, ma anche alle fonti letterarie. «trascrizioni indirette». Fra le risorse più comuni si ricordano le Sacre Scritture, ma ci sono anche altri scritti, come quelli dei padri apostolici, coloro che ebbero rapporti con gli apostoli; o quelli degli apologisti greci del II secolo; o alcuni scritti antieretici dello stesso secolo e quelli degli scrittori cristiani del III e IV secolo, tra cui si distingue Tertulliano con i suoi Ad Nationes e Apologeticum. D’altra parte, la Commissione di Archeologia Sacra istituita per un’idea dell’archeologo romano Giovanni Battista de Rossi venne riconosciuta come istituzione da Pio IX il 6 gennaio 1852 con la finalità di «custodire i sacri cemeteri antichi, per curarne preventivamente la conservazione, le ulteriori esplorazioni, le investigazioni, lo studio, per tutelare inoltre le più vetuste memorie dei primi secoli cristiani».
di FAUSTA SPERANZA
https://www.osservatoreromano.va/it/news/2023-10/quo-228/archeologia-di-fratellanza.html

 Saluto Prof. Luis Navarro
Saluto Prof. Luis Navarro Moderatore Dott. Alessadro Gisotti
Moderatore Dott. Alessadro Gisotti  Dott.ssa Fausta Speranza, Giornalista Inviato Esteri e Cultura
Dott.ssa Fausta Speranza, Giornalista Inviato Esteri e Cultura










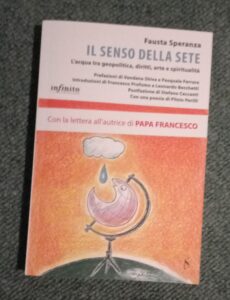



 INCONTRI LETTERARI
INCONTRI LETTERARI