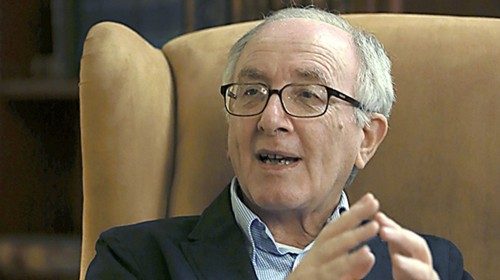di Fausta Speranza
La gravità e l’urgenza delle conseguenze del covid-19 per la salute pubblica e per l’economia richiedono misure immediate perché in ballo c’è la sussistenza di milioni di persone, ma anche perché si rischia che diventino un’opportunità per le mafie. In questi giorni, il Papa ha lanciato il suo monito perché non accada che qualcuno speculi sulle difficoltà dei più deboli e, in tema di legalità, è tornato a ribadire il suo appello contro ogni forma di corruzione. Non c’è, infatti, solo quella dei grandi sistemi, ma anche quella a livello di gente comune che rende possibile le altre modalità più gravi, come conferma Antonio Nicaso, uno dei massimi esperti a livello mondiale di mafie, docente tra l’altro di Storia sociale della criminalità organizzata alla Queen’s University.
«Le mafie sono rapaci» afferma Nicaso. «Hanno sempre trasformato le crisi in opportunità. La ‘ndrangheta, che oggi è l’o rg a n i z z a z i o n e illecita più ricca e potente al mondo, ha cominciato ad assumere un atteggiamento imprenditoriale dopo il terremoto del 1908 a Reggio Calabria e a Messina, quando ha cominciato a concedere prestiti a tasso d’usura. Le inchieste degli ultimi tempi ci hanno chiaramente “fotografato” l’opportunismo e la rapacità delle mafie anche in occasione dei vari terremoti avvenuti più di recente nel Centro Italia. Ci sono le registrazioni della telefonata in cui, pochi minuti dopo una scossa violenta, due faccendieri legati alla ‘ndrangheta si felicitavano dell’accaduto sorridendo per gli “affari” e i guadagni che avrebbero fatto».
Si è parlato in altri Paesi d’Europa del rischio che eventuali aiuti straordinari all’Italia arrivino in mano alla mafia. Cosa risponde?
Queste preoccupazioni, secondo me, sono discutibili, perché le mafie non operano solo in Italia. Da tempo sono attive in Olanda e in Germania perché quei Paesi consentono di fatto più di altri di investire, di riciclare denaro. Oggi, se dovessi indicare un posto dove la ‘ndrangheta è più radicata fuori dalla Calabria, dalla penisola non avrei nessuna difficoltà a citare la Germania. Il rischio non è solo legato ai soldi che possono arrivare dall’Europa, ma ai meccanismi di circolazione del denaro, come quelli che portano ai cosiddetti paradisi fiscali. E, dunque, il problema è in tutta l’Europa, se vogliamo fermarci al contesto europeo. È chiaro che in questa situazione bisogna tenere gli occhi aperti, fare una mappatura dei settori a rischio: quelli che possono finire più facilmente nelle grinfie delle organizzazioni criminali.
Per esempio?
Penso alla piccola e media impresa, che farà fatica ad andare avanti non potendo contare su utili. È importante intervenire con tempestività con aiuti piuttosto che perdere troppo tempo a discutere. Bisogna ridurre i margini di azione delle mafie. Possono sostituirsi alle banche qualora le imprese restino bloccate dalla burocrazia bancaria e da quella della pubblica amministrazione. È fondamentale intervenire per evitare che un’azienda possa andare in default economico e accettare il ricorso a soldi sporchi. Lo abbiamo già visto durante la crisi dei Subprime nel 2008, quando le mafie hanno cercato di acquisire quote di minoranza, quando hanno investito i soldi attraverso le banche. Questi sono i rischi peggiori da scongiurare e non soltanto in Italia ma un po’ dappertutto.
Ci aiuti a ragionare sull’accostamento di questi due termini: globalizzazione e organizzazioni internazionali.
Le mafie hanno certamente tratto vantaggio dalla globalizzazione dei mercati. Ma la prima cosa da dire è che non metteranno in discussione la loro globalizzazione in nessun caso. Ricordiamoci che sono riuscite ad internazionalizzarsi quando ancora nessuno parlava di globalizzazione. Il fenomeno esisteva — penso al pomodoro nato in America e divenuto alimento centrale nella nostra cucina o alla grande questione delle migrazioni di massa — ma non con queste modalità o con questa definizione.
Nella nostra storia recente ci sono dei momenti chiave?
Direi che c’è stata una sorta di spartiacque nella storia delle mafie: la caduta del muro di Berlino. Prima erano più circoscritte nell’Ovest d’Europa, poi sono riuscite a operare in Paesi dell’Est dove non c’era neanche emigrazione italiana. In mancanza di regole certe, alcuni faccendieri hanno approfittato della fase di transizione da un’economia pianificata a un’economia di mercato. Nella fase attuale, se pensiamo al mercato degli stupefacenti (cocaina, eroina, droghe sintetiche) le mafie sono concentrate sulla Cina, dove si parlerà, di qui a poco, di un mercato di 20 milioni di tossicodipendenti, o sull’Australia, dove un chilo di cocaina costa tre volte di più che in Italia.
Da una parte, c’è la legalità e, dall’altra, queste organizzazioni. In mezzo c’è una zona grigia, abitata da colletti bianchi, dalla disonestà diffusa a tanti livelli. È così?
Certo. Diciamo che se non ci fosse questa zona grigia non ci sarebbero le mafie. Le mafie da sempre hanno avuto bisogno di condotte agevolatrici per potersi affermare. Per i miei studenti utilizzo la formula chimica dell’acqua e spiego che i due atomi di idrogeno rappresentano la violenza, ma quello che fa la differenza è l’atomo di ossigeno, che è proprio il rapporto con questa zona grigia, con professionisti senza scrupoli. Se non ci fossero, le mafie farebbero molta più fatica a riciclare denaro.
Può citare un caso concreto?
Ricordo l’operazione Iscreen con la quale agli inizi degli anni Novanta un’organizzazione criminale internazionale è stata smantellata proprio perché faceva fatica a investire, a riciclare denaro. Aveva cominciato a depositarlo in una casa, ma alla fine non c’era più spazio per contenere il contante accumulato attraverso attività illecite. Ecco, il riciclaggio e l’investimento sono importanti nelle dinamiche di un’organizzazione criminale: si può rimanere “soffocati” dai soldi. Quindi, il rapporto con il mondo dell’imprenditoria, della politica, della finanza è fondamentale. Ci può essere corruzione senza mafia, ma non ci può essere mafia senza corruzione. Non riesco a pensare al crimine organizzato senza zona grigia.
Quanto è importante il reiterato appello di Papa Francesco a combattere la corruzione?
È fondamentale! La corruzione saccheggia risorse pubbliche che potrebbero sanare tanti squilibri sociali. E, soprattutto, tendiamo a sottovalutare il ruolo della corruzione per le mafie, che invece è centrale. Oggi le organizzazioni criminali sembrano invisibili perché non hanno quasi più bisogno di sparare. Sanno di poter utilizzare la violenza, ma, se possono evitare il clamore preferiscono. Sanno di avere in mano qualcosa di più efficace rispetto alle armi: la corruzione che permette alla mafia di radicarsi, di infiltrarsi senza fare rumore. E tanta gente presta consapevolmente il fianco o chiude gli occhi.
Per la crisi che sta scoppiando ora, c’è qualcosa da imparare da quella del 2007-2008?
Certo. Nel 2008 i soldi delle mafie sono stati un pilastro fondamentale per evitare di far crollare tantissime banche nel mondo. Lo denunciò Antonio Costa, l’ex direttore dell’Ufficio delle Nazioni Unite per il controllo della droga e la prevenzione del crimine (Unodc). Quindi, fa benissimo Papa Francesco a richiamare le coscienze di tutti.
Dopo i traffici di droghe, di armi, quello odioso di esseri umani, il riciclaggio di denaro sporco o gli investimenti illeciti nell’edilizia o nelle slotmachine, oggi si parla di dark web o di criptovalute. Il suo ultimo volume, scritto con il magistrato Nicola Gratteri ed edito da Mondadori, si intitola «La rete degli invisibili»: sono questi gli ambiti dove le mafie restano lontane dai riflettori?
La seconda capacità delle mafie, dopo quella relazionale, è quella di adattamento. Quello che un tempo si faceva nella gestione delle case da gioco, nelle bische clandestine, oggi si fa con il gaming on line. Vari Paesi, come per esempio Malta, acconsentono alla costituzione facile di società per il gioco su web, che nascono con i soldi che provengono da mafie. Per quanto riguarda le criptovalute, già si comincia a sentire in alcune intercettazioni il riferimento all’uso di bitmonero, o bitcoin per la vendita di partite di cocaina. E poi c’è il darkweb, un sistema cinquecento volte più grande della rete conosciuta come www. È un sistema di comunicazione dove non c’è timore di essere intercettati, si può vendere qualsiasi cosa. Alcune indagini hanno già messo in luce questa sorta di “Amazon del male”, in cui è possibile acquistare droga, armi, materiale pedopornografico.
In definitiva, quali vie indicare per il mondo post covid-19 che tutti sogniamo migliore?
Mi auguro che questa esperienza possa farci capire l’importanza di combattere le diseguaglianze sociali, di concepire forme di capitalismo che tengano conto del bene della comunità e non seguano solo la logica del “fare soldi per fare soldi”. Bisogna ricordarsi che problemi globali richiedono risposte globali.
Dunque, non è d’accordo con chi in questa fase mette in discussione in diverso modo tutto ciò che è avvertito come sovranazionale, agenzie delle Nazioni Unite o Unione europea?
È impossibile pensare di combattere le organizzazioni criminali o quelle terroristiche senza azioni concertate, senza maggiore coesione internazionale. È necessario globalizzare l’azione di contrasto alle mafie, che sono globalizzate. Oggi le mafie vanno a cercare i Paesi che si presentano come paradisi fiscali o normativi, perché lì le legislazioni sono meno affliggenti. E alcuni Paesi di recente guardano alle mafie come a un’opportunità più che a una minaccia, perché portano liquidità. Tutto questo perché mancano normative giuridiche adeguate. Abbiamo bisogno di organismi sovranazionali perché c’è molto da fare a livello legislativo per sanare alcune disparità.
Qual è la sua speranza?
Per me la speranza è costruire. Ognuno di noi deve pensare che non è vero che non può fare niente. Tutti possiamo fare qualcosa per cambiare le ingiustizie che abbiamo di fronte oggi. La mia speranza è che venga ascoltato l’altro richiamo di Papa Francesco di questi giorni, quello ai politici perché «non pensino al bene del loro partito ma al bene comune». C’è urgente bisogno di riscoprire il bene comune.
da L’Osservatore Romano del 27 aprile 2020