Tra libertà e potere, una riflessione sulle origini del “costituzionalismo” 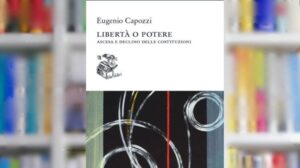
Tra guerre vecchio stampo e più o meno improvvisi ripensamenti dell’ordine mondiale, tra antiche diseguaglianze e moderne forme di rapacità economica, si discute della fragilità o meno delle democrazie occidentali mentre nuovi soggetti si palesano nel consesso delle decisioni politiche in virtù della potenza tecnologica che rappresentano. Un dibattito doveroso che rischia però di rimanere in superficie se non si torna a parlare dei fondamenti delle carte costituzionali, di quei valori condivisi su cui poggia il concetto di diritti umani inalienabili. E’ quanto mette in luce l’ultimo libro dello storico Eugenio Capozzi Libertà o potere. Ascesa e declino delle costituzioni (Macerata, Liberilibri, 2025, pagine 116, euro 15).
Intervista audio con Eugenio Capozzi
Viene subito in mente la difficoltà di parlare di valori nel contesto attuale che risulta segnato dal relativismo e stordito dall’inflazione dei diritti. Il professor Capozzi, ordinario di storia contemporanea presso l’Università Suor Orsola Benincasa di Napoli, affronta proprio questa sfida raccontando in estrema sintesi la profondità del percorso storico che abbiamo alle spalle e mettendo a fuoco con estrema chiarezza la posta in gioco.
Il primo passo: chiarezza sui termini
Si comincia con il chiarire alcuni fraintendimenti sui termini, partendo dal concetto di costituzione. Nel discorso pubblico i temi relativi alla politica e al diritto prima o poi vi fanno necessariamente riferimento, ma questo non vuol dire – avverte Capozzi – che il concetto sia generalmente adoperato a proposito, o che le sue varie possibili accezioni siano sempre pienamente comprese: “Spesso la sua evocazione superficiale e inflazionata favorisce un notevole margine di ambiguità e genera molti equivoci”. Pensandoci bene, tra le varie accezioni ce ne sono almeno due molto comuni. La prima è quando per costituzione si intende la “legge fondamentale” di un ordinamento politico alla quale le leggi ordinarie dovrebbero conformarsi. In questo senso viene considerata da un punto di vista puramente formale come documento approvato da un potere legislativo, benché speciale, qual è un’assemblea costituente. La seconda è rappresentata dall’uso del termine costituzione come sinonimo di “forma di governo”, dunque una tipologia qualsiasi di regime politico. Si comprende effettivamente che i margini di interpretazione si dilatano. Peraltro, al di là del linguaggio più comune, gli studiosi a volte parlano di costituzione anche per definire l’articolazione concreta di una società: dall’assetto socio-economico al diritto, dall’amministrazione alle istituzioni propriamente politiche.
L’Occidente non rinneghi la sua concezione etico-politica
In ogni caso, fin qui – ci fa capire Capozzi – non si arriva al cuore della questione. Riusciamo a farlo se parliamo di “costituzionalismo” intendendo non tanto la branca della scienza giuridica dedicata allo studio del diritto costituzionale, quanto piuttosto l’universo delle idee, costumi, norme, istituti finalizzati a difendere la libertà di individui e comunità contro abusi ed eccessi del potere politico. Capozzi si sofferma proprio su questa accezione etico-politica e sulla visione del mondo e dell’uomo formatasi nella storia di ciò che oggi chiamiamo Occidente, ribadendo che “le costituzioni sono valori, prima di essere dati di fatto”.
La superficialità che apre al “presentismo”
Si vuole discutere di libertà e potere e non di libertà o potere. Il punto però è che nella cultura diffusa, nella dialettica politica e spesso anche in quella intellettuale, questa priorità dei principi, e il loro effettivo significato, raramente emergono, sommersi da figure retoriche, polemiche di parte, generici e imprecisi luoghi comuni. Per non parlare della tendenza che Capozzi definisce “rudimentale presentismo”, cioè un appiattimento sugli ordinamenti liberaldemocratici occidentali contemporanei che non considera lo sviluppo storico con tutte le sue dialettiche. Significa ritrovarsi con ordinamenti che si presentano come contenitori svuotati di senso. Peraltro fare a meno dello spessore storico significa appiattirsi su una visione che perde di vista la complessità del mondo e questo alimenta l’illusione, ben nota, che tali modelli di regime liberaldemocratico siano naturalmente destinati ad estendersi su base planetaria.
L’urgenza di recuperare la concezione originaria di libertà
Guardare alle origini e allo sviluppo delle costituzioni, che oggi tendiamo a considerare come un dato ovvio e scontato, significa ritrovare un’idea molto antica di libertà dell’essere umano, connessa alla concezione filosofica e religiosa della sua dignità. Un’idea che prende forma tra la civiltà greca, quella romana e quella ebraica, e trova una sintesi peculiare nel cristianesimo, traducendosi in cultura, equilibri sociali, ordinamenti giuridici, istituzionali e politici. E’ proprio qui la forza della cultura costituzionale, che è sopravvissuta ai totalitarismi del Novecento non senza drammi e che – sottolinea Capozzi – “può continuare a svolgere una funzione di lievito, in grado di reagire in forma efficace ai profondi mutamenti delle diverse epoche”.
Il dramma di tagliare i riferimenti
Ci rendiamo conto che per quanto la maturazione di un’idea universalistica di diritti, libertà, dignità sia caratteristica essenziale dell’umanesimo occidentale ed elemento fondante della “tecnica” costituzionale, non può essere data per scontata la sua sopravvivenza, se si negano i riferimenti culturali, morali, religiosi condivisi che ne erano alla base. Si capisce la gravità di negare l’idea stessa di “un comune sentire”. Capozzi avverte: “Il mantenimento di un legame costante tra le società nate nella storia da una civiltà e le radici di quella civiltà in termini di rappresentazione del mondo e di principi fondanti non costituisce – come sostengono gli aedi del dirittismo – un freno alla libertà, ma al contrario la sua condizione primaria, il presupposto che consente agli individui viventi in quelle società di essere spiritualmente e culturalmente autonomi, e quindi di non soccombere al mito del potere demiurgico”.
Nello stordimento degli “aedi del dirittismo”
L’espressione “aedi del dirittismo” ben si comprende quando lo storico denuncia un dibattito intellettuale in cui “si adopera il termine diritti in modo confuso, generico, senza darne una definizione chiara e condivisa e senza il doveroso riferimento alla precisa concezione dell’uomo di cui sono emanazione”. Il risultato è sotto gli occhi di tutti: si mettono in un unico calderone diritti civili, politici, sociali, aggregando rivendicazioni che con l’una o l’altra di queste categorie, o con tutte, hanno in realtà poco a che spartire. L’avvertimento è preciso: “L’inflazione dei diritti ne svilisce la dignità”. E Capozzi individua anche la “matrice” di questo processo parlando di “’religioni secolari’ che propongono di smontare e ricostruire la società secondo un progetto di presunta razionalità totale”. A quel progetto è funzionale la “mutazione genetica della politica in cui l’intera eredità dell’umanesimo classico, ebraico-cristiano ed europeo si avvia ad essere completamente snaturata”, colpita dalla “azione corrosiva di nuove (ma per molti versi vecchie) ideologie”.
Le barriere contro l’abuso di potere ci sono ma vanno difese
Si comprende l’urgenza di ricongiungere le istituzioni occidentali alle loro radici di civiltà più profonde: quelle che dal nomos greco, dallo ius romano, dalla Legge ebraica conducono all’affermazione netta della centralità assoluta della persona umana, e della sua superiorità rispetto a ogni potenza terrena, asserita dall’umanesimo cristiano. Anche l’obiettivo è urgente: frenare la consunzione delle barriere contro l’abuso del potere, alla quale stiamo assistendo.
